|
|
Siete in: Home » La lenta corsa del tempo di Gabriele Maccianti
Libri in vetrina...
LA LENTA CORSA DEL TEMPO DI GABRIELE MACCIANTI
Siena di fronte alla modernità tra XIX e XX secolo
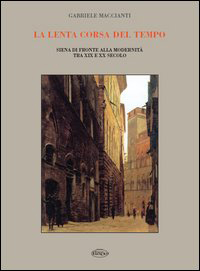 Il primo capitolo è dedicato al timido sviluppo urbanistico del primo cinquantennio post-unitario. L'aumento della popolazione cittadina pose in evidenza la necessità di migliorare le condizioni igieniche dei quartieri più popolari e di costruire nuovi insediamenti abitativi. La richiesta non proveniva dalle sole classi meno abbienti ma anche dalla borghesia, desiderosa di adottare gli standard abitativi moderni - abitazioni unifamiliari luminose, giardini, ecc. - diffusi dalle riviste alla moda. Per soddisfare queste esigenze, dibattute vivacemente sulla stampa, l'amministrazione comunale predispose nel 1889 un piano di espansione sulla collina di San Prospero prospiciente il vecchio centro abitato. Il piano non venne attuato sia per gli elevati costi sia per i timori nutriti da una parte autorevole della cittadinanza per l'eccentricità del nuovo quartiere rispetto al vecchio nucleo urbano. Uguale sorte subirono altri due progetti: il primo destinato alla medesima area di San Prospero (1900), il secondo, invece, alla valle intra moenia di Follonica (1908).
Il primo capitolo è dedicato al timido sviluppo urbanistico del primo cinquantennio post-unitario. L'aumento della popolazione cittadina pose in evidenza la necessità di migliorare le condizioni igieniche dei quartieri più popolari e di costruire nuovi insediamenti abitativi. La richiesta non proveniva dalle sole classi meno abbienti ma anche dalla borghesia, desiderosa di adottare gli standard abitativi moderni - abitazioni unifamiliari luminose, giardini, ecc. - diffusi dalle riviste alla moda. Per soddisfare queste esigenze, dibattute vivacemente sulla stampa, l'amministrazione comunale predispose nel 1889 un piano di espansione sulla collina di San Prospero prospiciente il vecchio centro abitato. Il piano non venne attuato sia per gli elevati costi sia per i timori nutriti da una parte autorevole della cittadinanza per l'eccentricità del nuovo quartiere rispetto al vecchio nucleo urbano. Uguale sorte subirono altri due progetti: il primo destinato alla medesima area di San Prospero (1900), il secondo, invece, alla valle intra moenia di Follonica (1908).
Pertanto la risoluzione del problema abitativo fu, di fatto, demandata all'iniziativa privata, e si tradusse con la costruzione, non regolamentata, fuori della cerchia muraria, di edifici di prevalente destinazione borghese. I progetti allegati alle domande di costruzione, custoditi presso l'Archivio Storico del Comune di Siena, evidenziano la marcata influenza esercitata dalle residenze aristocratiche sugli intendimenti estetici dei committenti borghesi.
Il secondo capitolo è invece dedicato ad aspetti più specificatamente estetici, e segnatamente al modesto grado di diffusione raggiunto a Siena dai linguaggi artistici d'avanguardia nei primi anni del Novecento. Per secoli, fino al Neoclassicismo e al Romanticismo, fino a quando il ritmo dei mutamenti politici, economici, sociali non aveva assunto il ritmo vorticoso proprio della modernità, i linguaggi d'avanguardia erano stati accolti e fatti propri - magari con lentezza e qualche diffidenza - dall'aristocrazia senese. Con il passare del diciannovesimo secolo la ricettività artistica della città diminuisce gradatamente. L'estetica Purista sopravvive molto più a lungo che altrove tra le intatte mura medievali, mentre le sperimentazioni dei Macchiaioli suscitano scarso interesse (nonostante la lunga frequentazione di Telemaco Signorini di un salotto aristocratico à la page) e i giovani artisti senesi più attenti alle novità e alle tensioni creative incontrano non poche difficoltà. L'art nouveau viene apprezzata da un ristretto numero di amatori e il Futurismo è oggetto di un'aspra riprovazione. Ne fornisce una prova la risposta della redazione de Il Libero Cittadino a una lettera indirizzatagli da Filippo Tommaso Marinetti.
Il terzo capitolo tocca argomenti più generali. La società senese, invece, dimostrò di comprendere l'importanza economica del movimento turistico sia dai primi anni del Novecento. Sono ancora in ombra alcune iniziative che giocarono un ruolo non secondario. La Mostra dell'Antica Arte Senese del 1904 fu accompagnata da una tambureggiante campagna educativa, destinata anche ai giovani, volta ad accrescere il rispetto per i visitatori e la pulizia della città. Nello stesso periodo fu elaborata una più articolata e funzionale fruizione del patrimonio artistico che venne ottenuta con una regolamentazione dell'apertura dei musei e delle raccolte d'arte. Il programma di restauro venne esteso anche ai modesti fabbricati destinati ad abitazioni, dapprima con i contributi economici elargiti dal Monte dei Paschi per il rifacimento delle facciate (1899-1903), poi, qualche anno dopo, con l'energica azione di tutela artistica condotta dalla commissione comunale edilizia (i cui poteri furono ampliati nel 1916 dopo furiose polemiche). Queste osservazioni introducono una riflessione sui ceti produttori di cultura a Siena. L'élite dirigente della piccola città toscana, di prevalente origine aristocratica, era un piccolo universo non privo di attenzioni per l'arte e la cultura ma chiuso verso l'esterno come testimonia indirettamente l'elevata percentuale di matrimoni contratti tra nobili di comune origine senese. Un ambiente posto ai margini dello sviluppo industriale dell'età giolittiana, contraddistinto da una marcata nostalgia per lo splendore artistico del medioevo (sentimento peraltro condiviso da gran parte della popolazione) e non certo stimolato dalla borghesia cittadina, subalterna culturalmente e - a causa della sostanziale stagnazione economica - priva di sbocchi economici autonomi.
La parte centrale dell'elaborato è dedicata a Fabio Bargagli Petrucci e alla sua attività nel campo culturale e artistico. Se sono già state messe adeguatamente in risalto le indiscusse doti intellettuali, il grande attaccamento alla città e le iniziative editoriali dell'aristocratico senese, è invece rimasto sotto silenzio una parte altrettanto importante della sua personalità. Gli scritti di Bargagli Petrucci, infatti, mostrano una marcata conoscenza del dibattito politico e filosofico contemporaneo e una chiara visione dei problemi che le élites dirigenti del suo tempo si trovavano di fronte. Come reagire alla crescente ingerenza delle masse nel mondo della politica? Come affrontare la progressiva scomparsa del sacro nella società? E, in termini ancor più generali, come reagire ai bruschi mutamenti provocati dalla società industriale?
Bargagli Petrucci, rifiutando un culto raffinato ma décadent della bellezza, sposa le tesi più vitalistiche elaborate da alcuni dei massimi rappresentanti del pensiero conservatore del suo tempo, come Friedrich Nietzsche e Gustave Le Bon. Bargagli ritiene che l'esperienza estetica sia uno dei nodi centrali dell'esistenza; "educare la classe operaia al culto del bello" e strapparla alle suggestioni della lotta di classe è uno suoi propositi principali. Siena deve puntare sul turismo culturale, sul rilancio delle scuole artistiche e sull'artigianato per trovare un suo modello di sviluppo, capace di assicurare un futuro alla città. Se questi progetti sono circoscritti all'ambito senese, Bargagli non nasconde l'ambizione che il piccolo laboratorio toscano possa fornire insegnamenti validi per molte altre realtà della policentrica Italia. Troppo spesso, finora, le vicende senesi sono state lette in una chiave eccessivamente autoreferente, originata dalla singolare dimensione di 'piccola capitale' della città toscana, e anche l'opera di Fabio Bargagli Petrucci è caduta in questo piccolo malinteso. Scopo di questo lavoro è anche evidenziare i rapporti esistenti tra un certo modo di percepire e diffondere la cultura artistica e la gestione del potere. Infatti, il processo di esaltazione della storia e dell'arte senese compiuto a cavallo tra Ottocento e primo Novecento può essere connesso, se osservato in un orizzonte di scala europea, con lo sforzo dell'aristocrazia di mantenere l'egemonia culturale in un contesto sempre più difficile. Il manifestarsi di una società impostata sulla produzione industriale e non sullo scambio di prodotti, il tramonto di un modello economico imperniato sull'agricoltura, la diffusione dell'ideologia socialista, erano guardati con timore e sospetto non solo dall'élite dirigente cittadina ma anche dagli strati sociali più umili e dalla borghesia (i primi desiderosi di marcare la propria differenza dai mezzadri e dai salariati agricoli che abitavano nelle campagne circostanti, e la seconda fortemente influenzata dai modelli nobiliari).
Il volto incontaminato e affascinante che Siena e la sua provincia suscitano in un numero elevatissimo di visitatori contemporanei, il magnifico grado di conservazione dei suoi monumenti, lo splendore delle sue collezioni d'arte sono in buona parte il risultato del programma culturale perfezionato da Bargagli Petrucci e accolto con favore da gran parte della società senese.
L'ultimo capitolo di questo lavoro è dedicato all'ampliamento della città sulla collina di San Prospero. Dopo la conclusione della prima guerra mondiale, sotto la pressione di una fortissima tensione sociale, il Comune intraprese il più volte rimandato programma di espansione urbana rispolverando il vecchio progetto accantonato alcuni decenni prima. L'insediamento, destinato prevalentemente alla borghesia cittadina, fu un paradigma quasi perfetto dell'immagine che i ceti dominanti volevano dare alla città, contraddistinto da caute aperture estetiche nei confronti di un Liberty del resto già tramontato nel resto d'Europa, e sorvegliato attentamente dalla Commissione edilizia del Comune, che controllò con grande attenzione gli elaborati predisposti dagli architetti cittadini. Un quartiere peraltro elegante e ben disegnato, marcato da una sua fisionomia e privo di quell'arbitrarietà comune, purtroppo, all'espansione edilizia del secondo dopoguerra.
Il desiderio di una città diversa da quelle ormai segnate dal fumo delle ciminiere trovò, pochi anni prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, un'ulteriore conferma nel progetto di Bargagli Petrucci di rialzare oltre quaranta torri medievali della città. Nel giugno 1935 i disegni illustranti il panorama della città modificato dalle torri furono mostrati a Mussolini nel corso di un'udienza concessa alle autorità senesi. La delegazione ottenne un'approvazione di massima dal Capo del governo. Pochi mesi dopo - nel maggio 1936 - all'indomani della conquista di Addis Abeba il Podestà chiese al Prefetto di inoltrare agli organi centrali dello Stato la richiesta di finanziamento dell'opera. La risposta fu negativa. Il governo, ormai, più che gli investimenti culturali - e ai ritorni economici del turismo - guardava alle necessità di una politica estera sempre più aggressiva e al conseguente potenziamento della produzione bellica. A questa vicenda, essendo cronologicamente distinta dal periodo sotto esame, sebbene faccia pienamente parte dell'argomento, è dedicata un'appendice.
|
